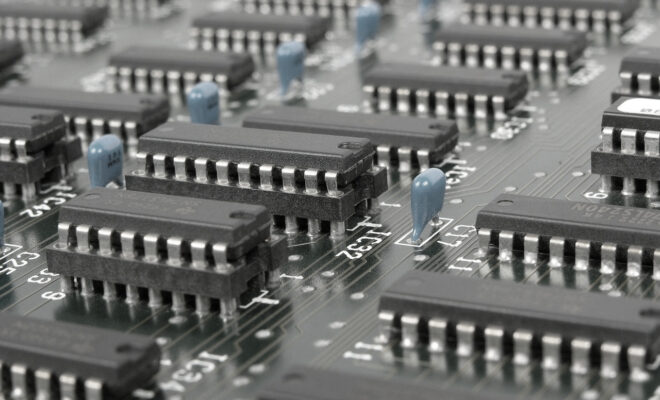Covid-19: il costo della crisi e i profitti dei ricchi in USA e UE

Nonostante negli USA il computo dei morti abbia lambito le 100.000 unità nel corso del week-end, la diffusione del contagio da Covid-19 negli Stati Uniti continua a esigere il suo tributo non solo in vite umane. Infatti non è da sottovalutare la rapidità con cui il divario tra élite economica del paese e la vasta maggioranza della popolazione si sta trasformando in una vera e propria voragine: a partire da marzo i miliardari americani hanno visto incrementare il proprio patrimonio collettivo del 15% di media in due mesi, si tratta di 434 miliardi di dollari – il 21% dei quali è finito direttamente nelle tasche dei Top Five, ovvero Jeff Bezos (di cui abbiamo parlato qui), Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet e Larry Ellison.
Nel frattempo, le richieste per il sussidio di disoccupazione hanno raggiunto l’allarmante cifra di quaranta milioni, che risulta indicativa ma largamente incompleta dato che non comprende tutti i lavoratori statunitensi che non potranno farvi ricorso per condizioni contrattuali che non lo permettono o semplicemente per il collasso delle infrastrutture amministrative assediate dalle richieste.

L’unica preoccupazione che sembra aver seriamente afflitto il governo americano è stata quella di ristabilire il mercato azionario ai livelli pre-pandemici: a tal proposito è servito il CARES act da un trilione (mille miliardi) di dollari, passato all’unanimità in Congresso, e il quantitative easing illimitato da parte della Federal Reserve, che pompa ottanta miliardi al giorno nel mercato azionario. Questi meccanismi combinati hanno gonfiato a dismisura la crescita dei patrimoni dei miliardari americani, in alcuni casi già estremamente favoriti dalle condizioni di vita (quindi di acquisto, di fruizione di servizi informatici ecc.) della popolazione imposte dal lockdown per contenere la diffusione del contagio.
Nello stesso periodo in cui ricchi hanno quindi utilizzato la pandemia per accumulare un’inverosimile quantità di capitale, la situazione per la vasta maggioranza della popolazione precipitava da “compromessa” a “senza via d’uscita” dal momento che le prospettive per il futuro sono anche peggiori: nei prossimi mesi, una grandissima percentuale di posti di lavoro persi non tornerà più. Secondo una ricerca del Becker Friedman Institute dell’Università di Chicago, il 42% dei posti di lavoro persi fino al 25 aprile saranno permanenti. Ciò significa che 11,6 milioni di persone non potranno tornare al lavoro, e non parliamo ovviamente di soli lavoratori dipendenti, ma anche di tutte le attività costrette a dichiarare bancarotta: è già facile individuare quanto la diminuzione di entrate tributarie per lo stato si tradurrà in massicci tagli alla spesa sociale, all’istruzione, alla sanità (già oltre qualsiasi limite di tolleranza) e così via.
In riferimento al diritto all’abitazione il quadro resta preoccupante: già da lunedì alcuni stati ricominceranno con la campagna di sfratto sospesa dalla moratoria sugli affitti. Il collasso del sogno americano, eliminando le prospettive di accesso ad un salario per i milioni di nuovi disoccupati, non solo andrà a cancellare ogni speranza di una vita dignitosa e di una casa per chi è già a stento sopravvissuto alla crisi del 2008, ma sarà la frusta che il padronato statunitense, economicamente e politicamente più potente che mai, impugnerà per demolire i diritti dei cittadini che avranno ancora un’occupazione.

E in Europa?
I dati ci dicono che l’aumento del tasso di disoccupazione nei paesi dell’Unione Europea si aggira attorno all’1%: nonostante le cifre (373.000 richieste di disoccupazione in Germania, 122.000 in Spagna, 144.000 in Italia) indichino sicuramente un aumento in percentuale allarmante rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+32,7% in Italia rispetto a marzo 2019), sono estremamente più contenute rispetto al tracollo del mercato del lavoro statunitense in quanto i governi hanno massicciamente fatto ricorso a manovre di sostegno dell’occupazione (Kurzarbeit in Germania e Austria, CIG in Italia ecc.) che hanno reso la situazione più o meno sostenibile sia per i lavoratori che per le imprese. Non va poi sottovalutato il fatto che, nonostante la soppressione delle legislazioni più avanzate in materia di difesa del diritto dei lavoratori, come l’Articolo 18 in Italia, licenziare un lavoratore in Europa è estremamente più difficile da un punto di vista burocratico e assai più dispendioso da un punto di vista economico rispetto alla stessa operazione negli Stati Uniti.
Inoltre, la qualità (intesa come importo monetario e benefici) delle forme europee di sussidio ai disoccupati è molto superiore a quelle statunitensi, essendo queste ultime molto più vicine alla soglia di sussistenza: fattore, questo, che limita di molto la diffusione rapida di situazioni di disagio sociale come quelle che si stanno già riscontrando negli USA.
 Possiamo però definirci al sicuro? Storicamente, gli strumenti di integrazione salariale sono temporanei e molto costosi per gli stati che li impiegano poiché, essendo finanziati in larga parte con i contributi dei lavoratori, prosciugano le casse degli istituiti di previdenza, che non possono quindi destinare quei fondi all’erogazione delle pensioni, all’assistenza sanitaria e agli altri servizi. La situazione è – o forse si dovrebbe dire “sembra” visto il numero di situazioni di difficoltà che già ora sono emerse per lavoratori e famiglie ad esempio in Italia – stabile solo per il momento, e non è affatto detto che con la tanto agognata ripartenza dell’economia le aziende abbiano bisogno di tutta la forza lavoro a tempo pieno dal momento che nel frattempo la domanda per svariate categorie di beni si è fortemente contratta. Il campanello d’allarme trilla minacciosamente se guardiamo alle situazioni di impiego massiccio di manodopera dipendente, ad esempio i grandi marchi automobilistici: a fronte di un crollo dei consumi, c’è già chi cerca di assicurarsi prestiti miliardari per salvaguardare i dividendi azionari, e anche chi, come Renault, non pago di aver già ricevuto rassicurazioni cospicue su un prestito del genere, minaccia piani di ristrutturazione aziendale per garantirsi “un risparmio di due miliardi all’anno”. Come? Ovviamente chiudendo tre centri di produzione e convertendone un quarto, per un totale di 1.500 lavoratori a rischio.
Possiamo però definirci al sicuro? Storicamente, gli strumenti di integrazione salariale sono temporanei e molto costosi per gli stati che li impiegano poiché, essendo finanziati in larga parte con i contributi dei lavoratori, prosciugano le casse degli istituiti di previdenza, che non possono quindi destinare quei fondi all’erogazione delle pensioni, all’assistenza sanitaria e agli altri servizi. La situazione è – o forse si dovrebbe dire “sembra” visto il numero di situazioni di difficoltà che già ora sono emerse per lavoratori e famiglie ad esempio in Italia – stabile solo per il momento, e non è affatto detto che con la tanto agognata ripartenza dell’economia le aziende abbiano bisogno di tutta la forza lavoro a tempo pieno dal momento che nel frattempo la domanda per svariate categorie di beni si è fortemente contratta. Il campanello d’allarme trilla minacciosamente se guardiamo alle situazioni di impiego massiccio di manodopera dipendente, ad esempio i grandi marchi automobilistici: a fronte di un crollo dei consumi, c’è già chi cerca di assicurarsi prestiti miliardari per salvaguardare i dividendi azionari, e anche chi, come Renault, non pago di aver già ricevuto rassicurazioni cospicue su un prestito del genere, minaccia piani di ristrutturazione aziendale per garantirsi “un risparmio di due miliardi all’anno”. Come? Ovviamente chiudendo tre centri di produzione e convertendone un quarto, per un totale di 1.500 lavoratori a rischio.
Tutto quindi fa pensare che i grandi monopoli capitalistici europei stiano utilizzando lo stallo concesso dagli strumenti di integrazione salariale e dagli aiuti fiscali e finanziari dei Governi per salvaguardare i propri profitti nel modo più sicuro possibile e, ovviamente, per meglio concertare il massiccio attacco ai diritti dei lavoratori, che arriverà probabilmente sul finire dell’estate, con la fine (si spera) della pandemia: la partita è solo rimandata e probabilmente quello europeo sarà un autunno di fuoco.