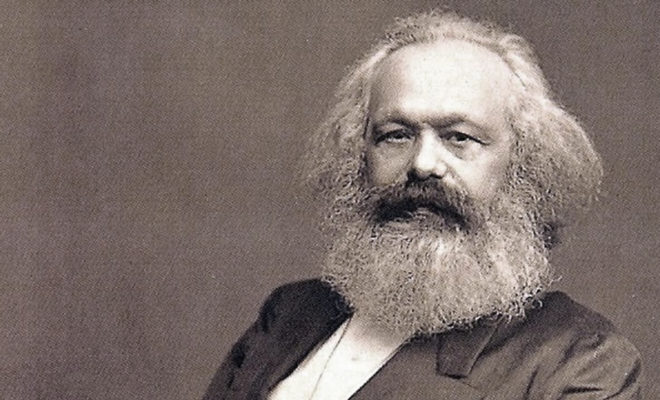La crisi che arriva, tra storytelling e paese reale

Un tempo l’avremmo chiamata semplicemente propaganda, mentre oggi, affascinati dagli anglicismi, preferiamo definirla storytelling, parliamo della capacità di saper narrare un paese facendolo apparire ben differente da come si presenta nella realtà. Una vera e propria tecnica comunicativa che si è progressivamente diffusa con la personalizzazione e la spettacolarizzazione della politica e che, mentre da un lato si è avvantaggiata del declassamento del ruolo dei partiti e dalla “fine delle ideologie”, dall’altro è stata amplificata dalla diffusione dei nuovi media e dalla trasformazione dei leader politici in veri e propri performer capaci di dare forma alle “sceneggiature” di qualche spin doctor. Come scrive Christian Salmon in un libro sul tema pubblicato da Fazi: lo storytelling degli uomini politici ha sostituito il racconto dell’azione con la distrazione alla deliberazione, la “statecraft” (l’arte di governare) con la “stagecraft” (l’arte della messa in scena).
Questi mesi di emergenza pandemica, passati da chi ci governa a tentare di convincerci a colpi di dirette Facebook che sarebbe andato “tutto bene” e che ne saremmo “usciti migliori”, sono forse l’esempio più alto dell’adozione di queste tecniche comunicative.
O quanto meno quello che, almeno fino ad oggi, sembra aver funzionato meglio, permettendo alle classi dirigenti di nascondere le proprie responsabilità nel disastro sociosanitario ed economico in cui siamo stati precipitati. Alcuni dati prodotti in queste settimane da centri di ricerca che non sono certamente in odore di socialismo, forniscono una stima dell’onda che si sta per abbattere sui lavoratori di questo paese. E lo fanno in maniera molto più realistica delle stime fornite da Gualtieri o dell’ottimismo cieco mostrato da Conte ogni volta che parla.
Secondo l’Istat nei primi tre mesi di pandemia conclamata i disoccupati “ufficiali” sono aumentati di 381.000 unità, un numero a cui vanno aggiunti quelli che il lavoro lo hanno perso, ma che non vengono considerati come disoccupati “attivi”, ovvero persone alla ricerca immediata di una nuova occupazione. Stando invece alle cifre fornite dall’Inps i lavoratori che, nello stesso periodo e in varie forme, sono stati interessati dalla cassa integrazione sono stati 6.825.000, circa il 35% dei salariati. Di questi cassintegrati, 1.200.000 sono concentrati nei comparti a bassa digitalizzazione ed alta intensità di manodopera generica o a bassa qualifica: turismo, ristorazione, commercio al dettaglio, servizi alle persone. Settori in cui più di un terzo delle imprese sono considerate a rischio fallimento e i cui lavoratori, finita la cassa integrazione, difficilmente ritroveranno il proprio posto di lavoro.
Tanto per avere un’idea dell’ordine di grandezza con cui saremo chiamati a fare i conti: con la crisi del 2008 e una contrazione del Pil del 7% vennero distrutti quasi un milione di posti di lavoro. Ebbene, per il 2020 la stima della Commissione Europea per il Pil italiano parla di una contrazione dell’11,2%, il che, tradotto in numeri, significa almeno 1.500.000 di occupati in meno nel corso di un solo anno.
 Posti di lavoro che non potranno essere riassorbiti nemmeno dall’eventuale rimbalzo economico negli anni a venire. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha dimostrato come il rischio di disoccupazione colpirà più duramente proprio fra i lavoratori dipendenti a basso reddito. In questa “zona rossa” ricadrebbero almeno: 138.000 lavoratori temporanei con contratto a termine in scadenza fra marzo e ottobre e con un reddito imponibile mensile di 962 euro; 264.000 dipendenti in società di capitali a rischio in un settore a rischio e con un reddito mensile di 1.099 euro e 426.000 dipendenti di ditte individuali in settori a rischio e con un reddito di 831 euro. In totale, nell’area dei più esposti al rischio disoccupazione, più della metà dei lavoratori (828.000 lavoratori) percepisce (o dovremmo dire percepiva) salari che in media si aggirano intorno ai 900 euro.
Posti di lavoro che non potranno essere riassorbiti nemmeno dall’eventuale rimbalzo economico negli anni a venire. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha dimostrato come il rischio di disoccupazione colpirà più duramente proprio fra i lavoratori dipendenti a basso reddito. In questa “zona rossa” ricadrebbero almeno: 138.000 lavoratori temporanei con contratto a termine in scadenza fra marzo e ottobre e con un reddito imponibile mensile di 962 euro; 264.000 dipendenti in società di capitali a rischio in un settore a rischio e con un reddito mensile di 1.099 euro e 426.000 dipendenti di ditte individuali in settori a rischio e con un reddito di 831 euro. In totale, nell’area dei più esposti al rischio disoccupazione, più della metà dei lavoratori (828.000 lavoratori) percepisce (o dovremmo dire percepiva) salari che in media si aggirano intorno ai 900 euro.
E questo ci introduce a un’altra questione enorme, ovvero l’effetto che la crisi sta già producendo sui working poor, i cosiddetti “lavoratori poveri”. Quelli che, nonostante siano occupati, non riescono a garantirsi con il proprio salario una condizione dignitosa.
Parliamo di oltre 2,9 milioni di lavoratori e lavoratrici (il 12,2% del totale) che sono sotto la soglia dei 9 euro orari e che per il 79% è rappresentato da “operai”. E a questi vanno poi aggiunti i 3,3 milioni di lavoratori irregolari e informali, di cui il 74,1% alle dipendenze di qualche padrone o padroncino e il 25,9% impiegato in lavori “autonomi”.
 Anche in questo caso i dati elaborati dal Censis sulle informazioni fornite dalla Banca d’Italia lasciano spazio a pochi dubbi. Almeno il 15% degli italiani ha visto dimezzarsi il reddito del proprio nucleo familiare, mentre un altro 18% ha subito una contrazione che va dal 25 al 50%. Sono i cosiddetti “acrobati della povertà”, quelli a cui la crisi ha dato la spinta definitiva verso il baratro. Gli “invisibili” che la politica ufficiale non vede, né tantomeno ascolta. Un pezzo del nostro blocco sociale con cui dovremmo capire come tornare in connessione sottraendolo alle sirene del populismo, una cosa più facile a dirsi che a farsi, ma senza cui sarà impossibile anche solo immaginare un nuovo ciclo di lotte di classe in questo paese.
Anche in questo caso i dati elaborati dal Censis sulle informazioni fornite dalla Banca d’Italia lasciano spazio a pochi dubbi. Almeno il 15% degli italiani ha visto dimezzarsi il reddito del proprio nucleo familiare, mentre un altro 18% ha subito una contrazione che va dal 25 al 50%. Sono i cosiddetti “acrobati della povertà”, quelli a cui la crisi ha dato la spinta definitiva verso il baratro. Gli “invisibili” che la politica ufficiale non vede, né tantomeno ascolta. Un pezzo del nostro blocco sociale con cui dovremmo capire come tornare in connessione sottraendolo alle sirene del populismo, una cosa più facile a dirsi che a farsi, ma senza cui sarà impossibile anche solo immaginare un nuovo ciclo di lotte di classe in questo paese.