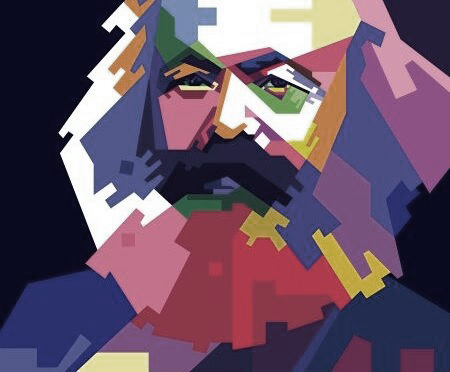La legge Calderoli – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione – è entrata in vigore il 13 luglio 2024 e sta, giustamente, conquistando sempre più spazio nel dibattito nazionale, anche grazie al grande successo della raccolta firme per il suo referendum abrogativo, che in poche settimane ha superato addirittura le 500.000 adesioni. Si tratta di una legge che, ricordiamo, è l’applicazione della riforma costituzionale del 2001 del Titolo V della Carta, voluta e fatta approvare dal centro-sinistra,1 e tuttavia sta diventando opportunisticamente oggetto di contestazione da parte dell’intera opposizione parlamentare, nonostante fino a poco tempo fa fossero gli stessi maggiori esponenti del PD a promuovere nelle loro regioni di pertinenza accordi per delle maggiori autonomie.2 In questo articolo non vogliamo comunque dilungarci sul tema di chi detiene le maggiori responsabilità politiche dello stato dei fatti quanto mostrare che l’applicazione della legge sull’autonomia differenziata coinciderebbe con un grave attacco ai diritti delle fasce popolari sia del meridione che del settentrione. Al di là della narrativa di stampo più marcatamente meridionalista che, a ragione, punta il dito soprattutto sulle disparità già esistenti tra le aree del Paese e alle potenziali nuove disparità che la norma favorirebbe, c’è da dire, infatti, che i maggiori beneficiari del provvedimento sarebbero costituiti dai monopoli capitalistici operanti al sud come al nord, favoriti dallo smantellamento dei servizi pubblici e dalla riduzione dell’agibilità democratica delle istituzioni. Questo punto di vista si ripercuote in maniera decisiva sulla comprensione di quale classe sociale (ovvero la classe lavoratrice) abbia, invece, degli interessi oggettivi a lottare contro la riforma. Ci occuperemo quindi dei due temi seguenti: le sperequazioni territoriali nella spesa pubblica fra le varie aree italiane e le prospettive di peggioramento della situazione con l’autonomia differenziata (paragrafi 1-2) e i benefici che da tale modifica alla gestione e alla distribuzione dei fondi saranno ottenuti dal padronato, a discapito dei ceti popolari di tutto il Paese (paragrafi 3-4).
- L’attuale distribuzione della spesa pubblica in Italia e il finanziamento dei servizi essenziali sui territori
Che l’investimento dello Stato italiano in servizi pubblici e infrastrutture sia altamente diseguale fra le aree del Paese è un fatto notorio. Secondo i dati dei Conti Pubblici territoriali, il 70,7% della spesa del Settore Pubblico Allargato in Italia (un aggregato più ampio di quello delle Amministrazioni pubbliche in quanto comprende anche le imprese partecipate dal pubblico, nazionali e locali, che producono servizi di pubblica utilità) continua ad essere concentrato nelle regioni del Centro-Nord, mentre il 29,3% nel Mezzogiorno, pur vivendo in questo più di un terzo della popolazione nazionale. In termini monetari, ogni abitante del Centro-Nord beneficia di circa 15.408 euro rispetto ai 11.948 euro dell’abitante del Mezzogiorno, con un divario medio di 3.460 euro pro capite tra Centro-Nord e Sud. Basterebbe questo dato per supporre che i fondi pubblici siano allocati per mezzo di una logica spiccatamente capitalista: più una regione risulta già industrializzata e produttiva, più fondi è “legittimata” a ricevere, al fine di massimizzare il profitto immediato del capitale privato in essa investito, grazie a elementi come l’efficienza infrastrutturale e l’ottimizzazione e la cura del “capitale umano”. Infatti, essendo la massa di capitale e di profitto maggiore al nord, è maggiore il fabbisogno di investimenti pubblici per mantenere la competitività di tale capitale. Al contrario, ogni investimento nelle regioni meno sviluppate ha, dal punto di vista della logica capitalista, per i primi anni, un carattere di un trasferimento a fondo perduto, poiché occorrono diversi anni affinché esso abbia l’effetto di sviluppare un apparato industriale e organizzativo adatto a competere con le aree sviluppate.
Da questo punto di vista, va già notato che i fautori dell’autonomia differenziata sostengono che proprio grazie ai famigerati Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), la cui applicazione è resa obbligatoria dalla normativa sull’autonomia differenziata nel momento in cui una regione decide di richiedere autonomie su determinati settori, lo Stato renderà obbligatori determinati livelli di equità fra i territori italiani. Vedremo nel prossimo paragrafo quali inganni e fraintendimenti possano celarsi dietro una determinazione formale dei fabbisogni fondamentali scaturita dalle istituzioni borghesi. Per adesso ci limitiamo a ricordare che la determinazione dei LEP non è ancora mai avvenuta, dal 2001 ad oggi, nonostante la costituzione di numerose Commissioni e Gruppi di Lavoro e sembra difficile che essi siano determinati in maniera razionale entro due anni, come imporrebbe la legge. In effetti, il passaggio da un sistema di finanziamento basato sulla spesa storica (come abbiamo visto, più bassa nei territori meno sviluppati) ad uno basato su parametri oggettivi di fabbisogno e di costo è tuttora assai complesso e arretrato, soprattutto tecnicamente, anche perché in questi anni è mancata la volontà politica di renderlo più adeguato.
Va detto, soprattutto, che sulle 23 materie sulle quali si potrebbe chiedere l’autonomia, ben 9 non rientrano nell’obbligo della determinazione dei LEP e possono essere decentrate subito sulla base delle intese Stato-regioni. Inoltre, la legge Calderoli è una legge ordinaria, il che significa che una successiva legge che trasferisce le competenze alle regioni potrebbe in linea del tutto teorica non rispettare il vincolo di determinare i LEP e quindi quello di finanziarli.
Si pone poi la questione del finanziamento dei LEP stessi, alla luce del fatto che la legge sull’autonomia differenziata si propone di definire e finanziare gli stessi a risorse invariate. Infatti, dall’applicazione della legge e delle conseguenti intese si legge che «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e al tempo stesso è garantita «l’invarianza finanziaria (…) per le singole regioni che non siano parte dell’intesa». La definizione dei LEP «ha dunque come obbligo il vincolo di bilancio, ma gli oneri per la finanza pubblica, laddove si volesse fare dei LEP un esercizio serio, finalizzato a risolvere le disuguaglianze nel diritto all’accesso, sarebbero davvero notevoli». Secondo i calcoli della Svimez «è credibile che per colmare il gap siano necessari almeno cento miliardi di euro».

Tutto lascia perciò presagire che i fondi saranno ricavati da tagli lineari su altre spese correnti o altri investimenti pubblici inerenti alle regioni oggetto della stessa intesa, o che a saltare sarà, per mezzo di qualche escamotage contabile o riforma ad hoc, proprio la disposizione per cui sarebbe garantita “l’invarianza finanziaria per le singole regioni che non siano parte dell’intesa”. Riassumendo, quindi, quanto detto finora, la distribuzione della spesa pubblica in Italia risulta estremamente diseguale privilegiando le regioni con più alto PIL e produttività e l’impostazione della legge sull’autonomia differenziata, lungi dal rappresentare una risoluzione del problema, rischia di consistere in una esacerbazione dello stesso. Vedremo ora più nel dettaglio le contraddizioni a cui possono portare le metodologie utilizzate per calcolare i fabbisogni dei singoli territori in un contesto di federalismo fiscale e le conseguenze in termini di rapporti di classe nel tessuto sociale.
- L’impostazione della legge Calderoli e le conseguenze sull’organizzazione del welfare state
Ciò che prevede la legge Calderoli è che gran parte del gettito dei contribuenti delle rispettive regioni rimanga nel bilancio delle regioni e che non sia più usato come leva di solidarietà a livello nazionale.3 Secondo la Svimez, infatti, se l’autonomia differenziata fosse stata attuata nel 2018, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto avrebbero avuto un surplus finanziario di circa 7 miliardi nei tre anni successivi, un ammontare sottratto a tutte le altre regioni italiane.
In effetti, l’ipocrisia del governo Meloni nel momento in cui parla di equità nella distribuzione delle risorse fra le regioni è resa già evidente da come è stato prosciugato nella legge di bilancio del 2024 lo stanziamento per il fondo perequativo infrastrutturale che doveva “bilanciare” l’autonomia differenziata: era costituito da 4,4 miliardi di euro, ne sono rimasti 800 milioni.
Detto questo, l’impianto della legge presenta diversi problemi da un punto di vista delle conseguenze organizzative dello Stato sociale. Prima di tutto, l’autonomia incontra il problema principale nella diminuzione della capacità dell’amministrazione centrale dello Stato di offrire servizi coordinati e pianificati. Abbiamo visto dall’esperienza Covid che la somma di 20 sistemi sanitari diversi è disfunzionale e meno efficiente rispetto a quello che sarebbe un SSN unico e centralizzato. Norme, convenzioni e livelli di operatività diversa paralizzano le risposte a problemi di portata nazionale, soprattutto in un contesto “fluido”, con persone e beni che si muovono di continuo anche a livello internazionale. Cosa accadrebbe al mercato del lavoro e alla produzione di servizi in generale quando lo stesso assetto sarà applicato a istruzione, ricerca scientifica, e tutto il resto?
Questo problema ha anche a che fare con la dimensione di importanti politiche pubbliche come quelle riguardo, ad esempio, l’energia e l’ambiente, dimensione che viene ricondotta al livello locale quando invece occorrerebbero, per la natura stessa di questi settori, politiche a dimensione nazionale. Le capacità delle economie di scala, la possibilità di gestire le esternalità complessive della produzione,4 la possibilità di distribuire razionalmente su un territorio vasto le risorse sono elementi che un sistema di servizi per la collettività non può trascurare se non vuole essere esclusivo e inefficiente.
Un secondo importante problema della legge Calderoli si collega con la richiamata formalizzazione dei fabbisogni “standard” nei diversi territori, concetto che dovrebbe essere alla base di una realistica applicazione dei LEP. L’esperienza del federalismo fiscale degli enti locali ci ha mostrato che, in questi casi, l’esplicitazione di tali fabbisogni non è mai immediata o equa. E questo è un problema soprattutto se le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni che richiedono forme di autonomia passano attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, così da diminuire il gettito fiscale per il resto del Paese, in modo che gli esecutivi nazionali e i loro organismi tecnici hanno tutto l’interesse a mantenere artificialmente bassi i fabbisogni delle regioni meno sviluppate al fine di non creare problemi al bilancio del Paese.
Questo è precisamente quello che è successo alle regioni del Meridione, fin dall’applicazione del federalismo fiscale ai comuni. Nel 2009-2010 si decise, infatti, di calcolare dei coefficienti dei fabbisogni standard parametrati sui servizi già in essere. I parametri per tale calcolo arrivavano all’assurdo, ad esempio, di considerare nullo il fabbisogno di asili nido di un paese che non possedeva asili nido, per il solo fatto di non possederli. Ad esempio, ancora, il fabbisogno in termini di viabilità aveva tra i criteri il numero attuale di veicoli circolanti e le presenze turistiche, come se questi fattori non fossero essi stessi influenzati negativamente dalle già pessime condizioni del territorio. Il fabbisogno scolastico era messo in funzione del numero di edifici, utenti della mensa, utenti trasportati da altri centri e quota delle classi a tempo prolungato già presenti.
Nell’applicazione del federalismo si decise, poi, di riservare il 55% del fondo di solidarietà pagato dai comuni tramite le entrate IMU e finalizzato alla perequazione dei suddetti fabbisogni, alla spesa storica, ovviamente più ampia al Nord.
Questo assetto è stato superato solo in parte e da pochissimo, con la nuova metodologia approvata nel 2020. Questo ha fatto passare il fabbisogno per abitante per i servizi sociali (ad esempio) dall’essere 78,92 per abitante a Reggio Calabria e 106,57 a Reggio Emilia nel 2020 ad essere 102,83 a Reggio Calabria e 101,67 a Reggio Emilia nel 2021. Ma gli effetti del sottofinanziamento ancora parzialmente in atto e protrattosi per anni e anni difficilmente saranno superati, specialmente in un contesto di progressiva esternalizzazione al privato dei servizi pubblici.
- Una riforma a favore della competizione tra regioni, dei grandi monopoli e dell’imprenditoria locale
Una riduzione ulteriore dell’equità nella spesa sociale e della capacità di programmazione dello Stato non avranno soltanto conseguenze sul piano meramente “distributivo”. Questi fattori apriranno la porta alla capacità del capitale privato di trarre vantaggio, oltre che dalla loro maggiore influenzabilità, dalla maggiore debolezza strutturale e organizzativa delle amministrazioni pubbliche nell’offrire direttamente servizi (un esempio recente è la denuncia fatta in Calabria circa l’inefficienza del servizio di emergenza-urgenza e la delega sempre più estesa di questo servizio al privato) e dalla corsa competitiva che fisiologicamente si produrrà fra le diverse regioni, che faranno a gara ad offrire condizioni più favorevoli all’esercizio spregiudicato della libera impresa al fine di incentivare l’afflusso di capitali, come accade già oggi tra le regioni a statuto speciale e quelle confinanti. Un cambiamento non solo quantitativo ma anche qualitativo, perciò.
La maggiore autonomia nel determinare i salari dei dipendenti pubblici, ad esempio, provocherà una fuga dei professionisti sanitari verso le regioni e le cliniche private in grado di offrire condizioni economiche più vantaggiose, impoverendo ulteriormente le risorse umane del Mezzogiorno e del settore pubblico. L’autonomia nella definizione del numero di borse di studio per scuole di specializzazione e medici di medicina generale determinerà una dotazione asimmetrica e inadeguata di specialisti e medici di famiglia, mentre le maggiori autonomie sul sistema tariffario rischiano di aumentare le diseguaglianze nell’offerta dei servizi e favorire l’avanzata del privato.

Soprattutto, il potere di programmazione pubblico in Italia sarebbe definitivamente compromesso a fronte dell’espandersi e del consolidamento proprietario ed organizzativo dei monopoli sanitari (es. Synlab, Affidea), assicurativi (Ass. Generali, Unipol ed altre), del controllo dei porti (MSC), del trasporto privato, e così via. Mentre la capacità di negoziazione e coordinamento della Pubblica Amministrazione andrà indebolendosi, i monopoli capitalistici continuano a potenziarsi grazie alla disponibilità di capitali d’investimento e alla finanziarizzazione. Altre materie per le quali verrà con tutta probabilità richiesta l’autonomia, tra le quali quella relativa a “Professioni”, sono tutte ad altissimo rischio di ulteriore privatizzazione e finanziarizzazione, e hanno a che fare con campi come, per esempio, la previdenza complementare e integrativa, o sono a rischio di “esternalizzazione” e appalto di servizi pubblici (come la protezione civile) o di esplicita competizione tra regioni (come il Commercio estero e i rapporti internazionali).
Quello che verrebbe favorito dall’autonomia differenziata è dunque la capacità dei privati di stringere legami, fare pressioni e ricatti sugli amministratori pubblici locali, dotati di meno mezzi rispetto allo Stato centrale per resistere a queste (e con più vicinanza “personale” alla grande e piccola imprenditoria locale, il che favorisce varie forme di collusione).
Un esempio paradigmatico di come la maggiore disponibilità di fondi sta venendo utilizzata dalle regioni non per ammodernare il servizio pubblico ma per offrire vantaggi al privato è la politica della regione Lombardia, la più ricca d’Italia. La Lombardia è la regione nella quale «è massima la concentrazione delle maggiori aziende che fanno business con la salute (San Donato, Humanitas, Gruppo Villa Maria, Kos, IEO, Maugeri, Gruppo GHC, Giomi Fingemi, Servisan, Multimedica), alcune ormai trasformatisi in multinazionali».
La Lombardia, d’altronde, è all’avanguardia del processo di privatizzazione del settore, avendo inserito nella nuova legge regionale la possibilità che le Case di Comunità siano affidate al privato. Nel territorio della città metropolitana di Milano, inoltre, negli ultimi mesi sono aumentati gli studi dei Medici di Medicina Generale situati all’interno di strutture gestite da realtà private che hanno collocato nello stesso stabile, talvolta nel medesimo corridoio, i propri specialisti.
I numeri testimoniano questa tendenza: «in Lombardia nel 2021 sono stati 6,4 i miliardi transitati nelle casse dei privati (erano 5,7 dieci anni prima) da quelle della regione, pari a quasi il 30% della spesa pubblica sanitaria regionale, circa 640 euro/persona/anno. In un anno la Lombardia ha pagato, attraverso le ATS e le ASST (le strutture equivalenti alle ASL) quasi 28 milioni di euro ai medici a gettone5 che ormai sono presenti in ogni ambito».
La capacità di gestire autonomamente i servizi pubblici da parte delle regioni è evidentemente, per i motivi che abbiamo citato, uno dei modi per accelerare il processo di privatizzazione degli stessi.
La competizione tra le regioni che si scatenerà in seguito alla nuova normativa rende peraltro palese, a prescindere dalle opportunità che questo offre al privato, che l’autonomia differenziata non creerà squilibri territoriali solo a danno del Mezzogiorno. Dai dati del Rapporto AHEAD di Cittadinanzattiva sulla desertificazione sanitaria ed in particolare sulla carenza di professionisti sanitari, emerge ad esempio che Asti e provincia contano pochi pediatri per numero di bambini (ogni professionista segue 1813 bambini fra gli 0 e i 15 anni, la media nazionale è di 1/1061 e la normativa prevede circa 1 pediatra per 800 bambini). A seguito della legge, la Lombardia potrebbe pagare di più i propri medici: se il più “povero” Piemonte non riuscisse a emulare la Lombardia si troverebbe a dover fronteggiare un’ulteriore carenza di medici.
- Una riforma che erode i margini di democrazia
L’autonomia differenziata, oltre l’aumento della sperequazione tra le regioni e del potere del capitale privato, contribuirà a erodere i margini di democrazia del nostro sistema. Questo è in contraddizione con la narrativa tipica dei promotori della riforma secondo i quali essa “avvicinerebbe il decisore politico ai cittadini”.
La verità è che la proposta sulle autonomie rafforza ulteriormente i poteri del Presidente del Consiglio rispetto al Parlamento. La legge approvata alla Camera prevede infatti che il Presidente del Consiglio abbia potere di avviare il negoziato con una Regione, di limitare l’oggetto a certe materie, di predisporre lo schema definitivo di intesa, di non conformarsi ad atti di indirizzo o a pareri delle Camere, di aggiornare i LEP e i costi con dei decreti (DPCM) scavalcando le Commissioni parlamentari e di disporre la cessazione di intese.
Allo strapotere del Presidente del Consiglio si aggiungerà, ovviamente, la previsione di delegare sempre più materie a istituzioni nelle quali vige già da tempo una forma di presidenzialismo in cui le assemblee legislative sono svuotate: le regioni, appunto. Più che “avvicinare al popolo” la gestione di determinati settori questa riforma rinforzerà quel tipo di verticalità e concentrazione del potere borghese che si è cristallizzato dentro le istituzioni regionali.
L’erosione dei margini di democrazia è d’altronde perfettamente funzionale alla necessità, da parte delle istituzioni stesse, di accelerare la ristrutturazione capitalistica, fatta di tagli a servizi pubblici e salari, a seguito delle numerose crisi di sistema che abbiamo avuto negli ultimi anni.
Conclusioni
Da quello che abbiamo osservato si può affermare che la legge per l’autonomia differenziata abbia come finalità principale un depotenziamento della capacità negoziale delle amministrazioni pubbliche al fine di favorire accordi maggiormente favorevoli al capitale monopolistico – e non solo – privato. Questo non vuol dire negare l’impatto su questa legge, e sulle politiche dei governi che hanno contribuito in questo percorso, dell’ideologia “aziendalista” e “meritocratica” che mira a far permanere maggiori fondi sui territori che producono un più alto prodotto interno lordo pro capite. Si tratta però di trasferire l’analisi dalla falsa contrapposizione “nord-sud” alla contrapposizione di classe. Se si osserva come i fenomeni della competizione al ribasso per attirare capitali, delle esternalizzazioni, delle privatizzazioni e, dunque, dello smantellamento del servizio pubblico sarebbero favoriti a prescindere dalla ricchezza o dalla povertà della regione, si arriva a concludere che la volontà di giungere a una gestione diretta dei fondi provenienti dalle imposte locali non costituisce tanto un effetto del “pregiudizio del settentrione contro il meridione”. Piuttosto, è questo pregiudizio ad essere un epifenomeno dell’obiettivo materiale di porre più liquidità possibile nelle mani della gestione localistica che presenta le caratteristiche che abbiamo riconosciuto. L’autonomia differenziata è dunque una questione principalmente di classe, che cristallizza come suo utile effetto sovrastrutturale il pregiudizio contro la redistribuzione finanziaria centralizzata verso il “meridione arretrato e sprecone”.6 Questa conclusione porta con sé la conseguenza politica per la quale, visto che, ad esempio, i vantaggi dell’autonomia differenziata e dello smantellamento del settore pubblico andranno anche all’imprenditoria meridionale, è la classe proletaria tutta a poter e dover organizzare un concreto e reale movimento di opposizione a questo provvedimento. Ciò sarebbe l’esatto opposto delle iniziative interclassiste e territorialiste che mirano a “boicottare la proposta” attraverso meccanismi come l’acquisto di sole merci prodotte al Sud. Si può, anzi, affermare che la “spaccatura” del Paese portata avanti dall’autonomia differenziata sia uno dei mezzi del potere borghese per incrementare il potere negoziale del padronato dividendo la classe operaia e tentando di mettere i proletari delle diverse zone d’Italia gli uni contro gli altri.
1 – In particolare, ricordiamo la Terza Bicamerale (Commissione per le riforme costituzionali, istituita con legge cost. n. 1 del 1997, governo Prodi I) è stata istituita grazie all’accordo raggiunto tra il Polo (centrodestra) e la maggioranza di centro-sinistra. Nonostante i suoi lavori siano stati interrotti nel 1998, la Commissione Bicamerale ha avuto il “merito” di indirizzare il dibattito su temi di estrema importanza per la futura riforma del Titolo V e i frutti del suo lavoro hanno contribuito alla definizione delle nuove previsioni costituzionali contenute in esso. Il programma di revisione costituzionale varato dal Consiglio dei ministri nel marzo 1999 (progetto D’Alema–Amato) ha anticipato poi alcuni aspetti fondamentali della successiva legge n. 3/2001. Dai lavori della Commissione Bicamerale e dal progetto D’Alema sono derivati quindi gli spunti propositivi decisivi che sono stati ripresi e tradotti in norme dalla legge 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione. Il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001, approvato dal referendum costituzionale di ottobre, è stato quindi prodotto dal governo Amato II, espressione di quello che sarebbe diventato successivamente il PD (Ulivo – PDCI – UDEUR) e che aveva tra le sue fila esponenti apicali del PD di oggi, come Enrico Letta che era Ministro dell’Industria, Dario Franceschini (sottosegretario alle riforme costituzionali), Piero Fassino (Ministro della Giustizia) e Pierluigi Bersani, (Ministro dei Trasporti).
2 – La regione Emilia-Romagna a febbraio 2018, per esempio, sotto la presidenza di Bonaccini, ha firmato il primo accordo preliminare con il governo per l’ottenimento di ulteriori forme di autonomia, accordo del quale si è votata la prosecuzione a maggio 2020, quando Elly Schlein era vicepresidente della regione.
3 – Francesco Pallante, professore ordinario diritto Costituzionale università di Torino.
4 – Le conseguenze negative che una certa attività ha sul proprio contesto e che non fanno parte del bilancio economico o dei piani di produzione dell’attività stessa, come ad esempio l’inquinamento, la creazione o perdita di posti di lavoro, etc…
5 – Per “medico a gettone” si intende un professionista, generalmente iscritto a delle cooperative private, chiamato per colmare le carenze del personale medico regolare o per coprire turni particolarmente intensi.
6 – Va chiarito che ciò che il testo afferma non è che il sud usufruisce di meno soldi pubblici pro capite perché non esiste attualmente una “redistribuzione delle risorse”. In realtà essa esiste (il residuo fiscale pro capite è più alto al nord) ma non è sufficiente, oltre ad essere accompagnata, in ogni regione del Paese, da un’allocazione disfunzionale dei finanziamenti (sprechi di denaro pubblico verso i privati, clientelismi e personalismi locali, etc..).