Il 20 dicembre del 1922, le squadracce fasciste guidate da Piero Brandimarte – e istigate dal ras Cesare Maria de Vecchi – portarono a compimento quella sarà poi definita la strage di Torino. Dopo due giorni di repressione e omicidi, i comunisti e gli antifascisti torinesi pagarono un tributo di sangue di quattordici vittime (anche se Brandimarte ne rivendicava ventidue, ironizzando sui numeri ufficiali) e una trentina di feriti. Con la scusa di voler vendicare l’uccisione di due fascisti – i quali avevano aggredito l’operaio comunista Francesco Prato trovando la morte per la reazione di quest’ultimo – con l’acquiescenza della prefettura e sotto spinta della borghesia industriale locale, le squadracce fasciste ebbero carta bianca per sfogare il loro terrorismo sui lavoratori e le loro organizzazioni. La provocazione, messa in atto allo scopo di falcidiare e ridurre al silenzio la resistenza operaia torinese, era stata calcolata con freddezza (1).
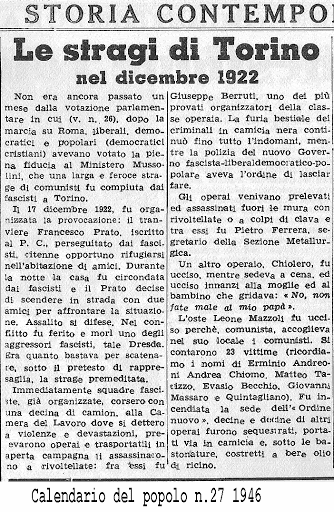
In foto una pagina di Calendario del popolo che ricorda i fatti.
Questo trova riscontro anche nelle dichiarazioni di Brandimarte, il quale, dopo la strage, candidamente ammise ai cronisti che l’operazione non solo non era stata estemporanea ma, al contrario, frutto di un lavoro di schedatura di dirigenti e operai comunisti (cita una lista di tremila nomi) che avrebbero dovuto pagare per la loro opposizione al regime e ai capitalisti(2). Fra le vittime della carneficina vi furono Carlo Berruti, segretario del sindacato dei ferrovieri di Torino, nonché consigliere comunale e membro del Partito Comunista d’Italia (PCdI) e Pietro Ferrero, segretario torinese della FIOM, attivo nello “sciopero delle lancette” dell’aprile del ’20 , il quale venne seviziato e trascinato per le vie della città legato ad un camion.
Oltre l’assassinio premeditato di comunisti e antifascisti, la spedizione ebbe come obiettivo le sedi della Camera del Lavoro, del circolo “Carlo Marx” e de “L’Ordine Nuovo”.
La sede del giornale fondato il 1o maggio del ’19, proprio a Torino, da Antonio Gramsci, venne devastata dai fascisti che, per di più, sequestrarono i tre redattori: Montagnana, Viglongo e Pastore, più altri tre collaboratori, e li portarono alla Casa del Fascio. Qui furono bastonati dagli squadristi, anche per cercare di estorcere loro informazioni su dove si trovassero Gramsci e altri dirigenti torinesi del Partito; successivamente vennero fatti sfilare e messi al muro, in una macabra simulazione di fucilazione che aveva come scopo quello di terrorizzare gli aggrediti (3). Tutto questo si consumò nell’indifferenza del neo-nominato prefetto, Carlo Olivieri, accreditatosi presso i fascisti grazie ai “servigi” già profusi nei mesi precedenti al ras di Puglia, Caradonna, quando era prefetto di Bari. Olivieri, ad ogni modo, diede ulteriore prova di fedeltà al nuovo regime anche a Torino, dacché ebbe a inaugurare la sua nomina nel capoluogo piemontese proprio con una perquisizione ai danni de “L’Ordine Nuovo” nel settembre ’22, inoltre non mosse un dito quando le squadracce, il 29 ottobre successivo, compivano un raid contro la sede del giornale.
L’attenzione che i fascisti torinesi, sia a livello istituzionale sia a livello di squadrismo, riservarono a “L’Ordine Nuovo”, rivela la sua importanza nel quadro di una delle maggiori realtà metropolitane e industriali del Paese. È da ricordare come il PCdI non fosse all’epoca, ancora, un partito di grandi dimensioni: sul territorio nazionale si contavano circa 23.000 iscritti, e alle elezioni dell’anno precedente si era attestato intorno al 4,5%. Eppure, nonostante i numeri ridotti, furono i comunisti ad essere le vittime principali della violenza degli squadristi, oltre che del regime stesso. Questo anche perchè gli industriali, che erano stati fra i promotori della strage, avevano sempre più intenzione di “normalizzare” ad ogni costo la situazione di agitazione nelle fabbriche; e, se vi era chi davanti al compito di dare battaglia al padronato mostrava segni di cedimento e tendenze al compromesso (4), i comunisti, come dimostrano gli appelli lanciati dalle stesse colonne de “L’Ordine Nuovo”, rimanevano in prima fila a combattere e frustrare le aspettative di normalizzazione della borghesia (5).
I crimini perpetrati dalle squadracce, naturalmente, non furono perseguiti dal regime di Mussolini. Al contrario, quest’ultimo s’affrettò ad emanare, proprio in quell’occasione, due giorni dopo la strage di Torino, un decreto di amnistia (Regio Decreto 1641 del 22 dicembre 1922) che condonava tutti i crimini e le violenze compiute “per un fine nazionale”, per garantire “l’ordine sociale”.
Chiaramente un provvedimento del genere intendeva fornire un salvacondotto totale per tutte le violenze del terrorismo squadrista, e, al contrario, condannare le “violenze” di chi si difendeva dalle brutalità dei fascisti e dei padroni. L’impunità per i crimini fascisti fu in molti casi anche il tratto distintivo nei processi nel dopoguerra, a fascismo sconfitto. Nella neonata repubblica la borghesia mentre da un lato s’affrettava a mettere sotto processo i partigiani infliggendo loro pene talvolta durissime, dall’altra condannava a pene irrisorie i vecchi arnesi del regime fascista (vi abbiamo fatto cenno ad esempio qui).
Il capo della spedizione, Piero Brandimarte – criminale fascista delle origini, arruolato nella cosiddetta “La Disperata”, una delle primissime squadracce (2) – fu condannato, nel 1950, a 26 anni di reclusione, ben due terzi dei quali tuttavia condonati. Di più, addirittura due anni dopo, nel ’52, fu assolto per insufficienza di prove, nonostante le sue dirette dichiarazioni e le sue responsabilità innegabili, finendo addirittura per aver tributati gli onori militari al suo funerale, nel 1971. Una sorte non troppo dissimile toccò a De Vecchi, uno dei caporioni mussoliniani della prima ora che, fuggito nel ’47 in Argentina, grazie anche alle complicità del Vaticano, ritornò in Italia già nel ’49, quando la condanna di cinque anni che gli era stata inflitta gli fu pienamente condonata.
Fabrizio Fornaro









